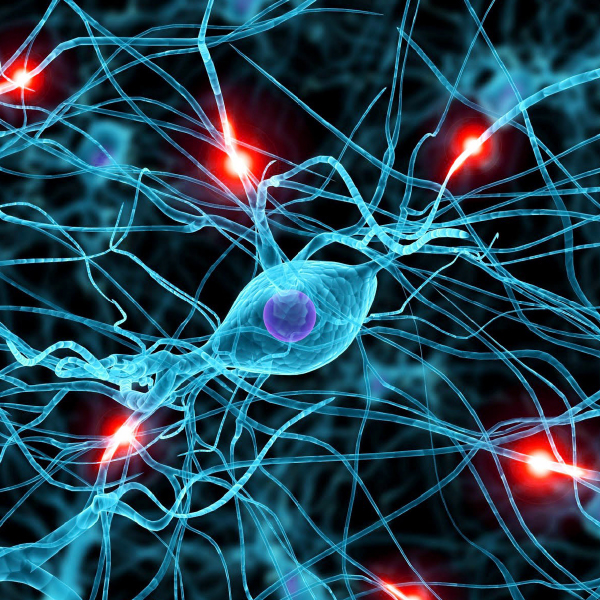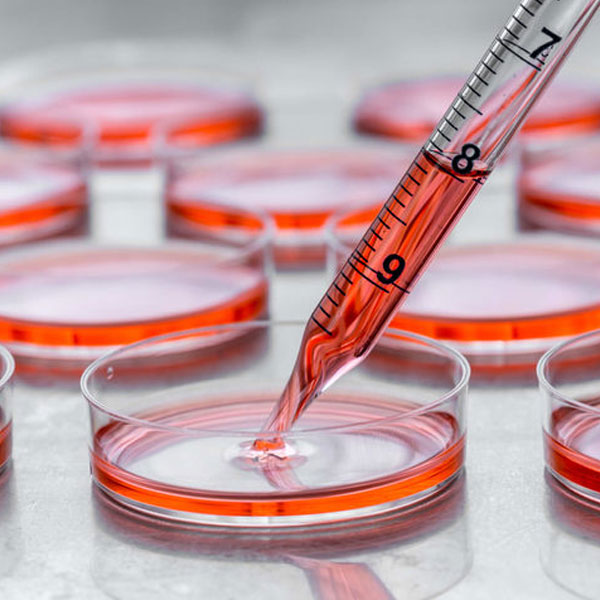News scientifiche
Scoperto a Torino un inibitore del gene che causa la crescita dei tumori ai polmoni, al colon e al pancreas
coperto a Torino un inibitore del gene che causa la crescita dei tumori ai polmoni, al colon e al pancreas
Uno studio sperimentale portato avanti da un team internazionale con esperti dell’Università di Torino e dell’IRCCS Candiolo potrebbe aprire nuove prospettive nella lotta contro alcuni tipi di tumore, come il cancro ai polmoni, al colon e al pancreas.
LO STUDIO
Lo studio, intitolato Egfr blockade reverts resistance to KRASG12C inhibition in colorectal cancer, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Cancer Discovery.
Condotto da Alberto Bardelli, direttore del Laboratorio di Oncologia Molecolare all’Irccs Candiolo e coordinato dal Sandra Misale, dottorata dell’Università di Torino e ricercatrice associata al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, lo studio ha esaminato su modelli cellulari gli effetti di un farmaco sperimentale, AMG510, che agisce da inibitore del gene KRAS G12C,uno dei geni mutati più comuni nei tumori umani e responsabile della loro espansione.
Considerato da decenni un gene incurabile, grazie alla una nuova classe di inibitori covalenti, tra cui AMG510, è stato possibile inibire una delle mutazioni del KRAS, la G12.
Sono risultati promettenti quelli emersi dalla ricerca in questione, anche se, per il momento, sono maggiori gli effetti positivi ottenuti sui malati di cancro ai polmoni.
Per le cellule del cancro al colon-retto la crescita viene ostacolata solo marginalmente e per un breve periodo di tempo.
“In questo lavoro abbiamo cercato di comprendere i meccanismi alla base delle differenze di lignaggio nelle cellule del cancro ai polmoni e del cancro al colon-retto.”, spiega Sandra Misale. “I dati ci dicono che, nonostante ospitino la stessa mutazione, ci sono differenze intrinseche nel manifestarsi tra i due tipi di cancro, che si traduce in sensibilità diverse dell’inibizione del gene KRAS G12C. Queste scoperte hanno una rilevanza immediata per i pazienti affetti da cancro al colon-retto con un tumore causato dalla mutazione del gene KRAS G12C”.
Dopo l’applicazione su modelli in vitro preclinici, ora si attende solo la sperimentazione del farmaco sull’uomo.
Nuovi risultati nella lotta contro il Covid-19 dalle cellule staminali
Anche dalla Spagna arrivano i primi risultati di una sperimentazione clinica basata sull’infusione di cellule staminali mesenchimali su pazienti affetti da Covid-19.
Avevamo già parlato in un articolo precedente del ruolo centrale assunto dalle cellule staminali nella lotta contro il Covid-19.
PERCHÉ LE STAMINALI CONTRO IL COVID-19
Quando il virus SARS-CoV2 infetta il sistema immunitario dell’uomo in molti casi può svilupparsi come conseguenza una polmonite interstiziale. Il trattamento utilizzato per contrastare la polmonite è la ventilazione forzata del paziente, trasferito in rianimazione. La condizione di ventilazione forzata attiva il sistema coagulativo generando il rischio di processi trombotici, una delle concause che porta al decesso.
Per evitare la rianimazione, con i risvolti negativi conseguenti, sono state utilizzate diverse terapie farmacologiche da parte dei medici.
Le terapie attuate, purtroppo, su alcuni pazienti non attecchirono. In questi casi il trattamento con le cellule staminali mesenchimali poteva rivelarsi una speranza di salvezza, visto la loro azione anti-infiammatoria. Riducendo l’infiammazione si diminuiscono i processi che attivano il sistema coagulativo, portando alla riabilitazione dell’organismo.
LO STUDIO CLINICO BALMYS-19
Per lo studio Balmys-19, guidato dal Dr. Filipe Prosper dell’Università di Madrid, sono state arruolate 13 persone alle quali la somministrazione di antivirali e anti-infiammatori non aveva prodotto risultati. I pazienti, infatti, erano finiti in rianimazione con ventilazione forzata e, per questo, vennero scelti per il trattamento.
I dosaggi che ricevettero furono diversi: dieci pazienti due dosi, due pazienti una dose e un paziente tre dosi. Una dose media di cellule staminali mesenchimali era di 980.000 cellule per kg di paziente.
Successivamente all’infusione nessun paziente trattato ha manifestato sintomi avversi, mostrando il miglioramento di diversi parametri analizzati.
Passati 16 giorni, nove pazienti, cioè il 70%, hanno presentato miglioramenti e, tra questi, sette sono stati estubati e dimessi dalla terapia intensiva, dando prova degli ottimi risultati ottenuti dal trattamento.
L’infiammazione diminuì in tutti i pazienti e aumentò, al contempo, il livello di leucociti. Quest’ultimo dato dimostra la reattività del sistema immunitario.
È stato dimostrato infine che i miglioramenti avvenivano sia se le cellule staminali impiegate erano estratte da tessuto fresco sia se si trattava di cellule congelate.
In conclusione allo studio è stata raccomandata dai ricercatori molta prudenza, visto che le terapie cellulari, a differenza delle altre, sono considerate “farmaci vivi” e, per questo, devono essere somministrate da personale medico altamente qualificato, sotto la sorveglianza delle autorità sanitarie.
Sclerosi multipla: una speranza dalle cellule staminali
Si è conclusa la sperimentazione di Fase 1 condotta dal Dottor Angelo Vescovi dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo che prevedeva il trapianto di cellule staminali cerebrali umane in 15 pazienti affetti da sclerosi multipla secondaria progressiva.
TERMINE DELLA SPERIMENTAZIONE
Nella giornata del 20 maggio è stato rilasciato l’ultimo paziente sottoposto alla sperimentazione autorizzata dalle commissioni dell’Istituto superiore di sanità e dell’Agenzia italiana del farmaco, Aifa.
Malgrado l’emergenza Covid-19 i clinici, i responsabili della produzione del farmaco, i ricercatori, i neurologi ed i neurochirurghi del team sono riusciti a tutelare i pazienti non interrompendo, al contempo, la sperimentazione.
Nessuna delle 15 persone sottoposte al trattamento ha manifestato effetti collaterali. Per avere i risultati finali però bisognerà attendere: “Aspettiamo adesso il follow-up a un anno e la sottomissione nei tempi più brevi possibili del protocollo per la Fase II in questa grave malattia”, ha affermato il Dott. Vescovi.
Si tratta di un primo passo verso l’istituzione di un protocollo sperimentale che permetterà di trattare i pazienti affetti da sclerosi multipla con l’infusione di cellule staminali.
LA TERAPIA
I pazienti previsti dalla terapia sono stati suddivisi in quattro gruppi. Le dosi sono state trapiantate in maniera crescente: gli ultimi sei hanno ricevuto il dosaggio più elevato (24 milioni di cellule). Passate le 48 ore di osservazione a seguito al trapianto, tutti i 15 pazienti sono stati dimessi e nessuno di loro ha manifestato effetti collaterali nell’immediato post-operatorio o nei mesi successivi.
Adesso i pazienti verranno seguiti per un anno, un anno e mezzo, anche se si cercherà di prolungare questo termine. Di primaria importanza sarà ottenere la conferma che nel tempo il paziente non abbia effetti negativi.
Questa sperimentazione si differenzia dalle precedenti per via del maggior tempo, fatica e costi impiegati. I pazienti prima di ricevere il trapianto sono stati monitorati nelle loro parti neurologica e clinica per tre mesi, in maniera tale da verificare se, per caso, le cellule staminali infuse avessero inciso in maniera positiva o negativa su tali aspetti.
Al momento, oltre alla non manifestazione di effetti collaterali, sono stati riscontrati, in alcuni pazienti, dei chiari effetti benefici. Questo fornisce gli elementi per procedere ad una sperimentazione più ampia e più mirata che porti alla determinazione e allo sviluppo di una vera e propria cura.
ULTERIORI STUDI EFFETTUATI IN ITALIA
Questo caso non è l’unico verificatosi in Italia. L’anno scorso il Direttore Scientifico dell’IRCCS Ospedale San Raffale di Milano, Gianvito Martino, aveva annunciato la conclusione della fase di trapianto delle cellule staminali neurali in 12 pazienti con sclerosi multipla coinvolti nello studio STEMS, finanziato dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM). Durante il congresso nazionale FISM, Martino aveva dichiarato: “Solo tra due anni concluderemo lo studio e cioè quando anche l’ultimo paziente trapiantato completerà i due anni previsti di follow up”.
Resta che, ad oggi, i risultati di questo primo studio continuano ad essere positivi: 9 pazienti dei 12 trapiantati hanno completato il follow-up di due anni senza manifestare effetti collaterali importanti, mentre gli ultimi 3 pazienti trapiantati hanno già concluso senza complicazioni il primo anno di follow-up accingendosi a completare il secondo anno.
Cellule staminali: incoraggiante terapia contro il COVID-19
LA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2
Nessuno poteva immaginare che nel giro di un paio di mesi un virus appartenente a una famiglia a noi nota, quella dei Coronavirus, evolvesse in una maniera tale da costringere l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a dichiarare lo stato di pandemia che ha coinvolto il mondo intero.
La diffusione a macchia d’olio del SARS-CoV-2 e le ripercussioni sulla salute umana hanno fatto sì che numerosi studiosi di ogni settore sanitario abbiano intrapreso una lotta contro questo agente microscopico che sta cambiando la vita di tutti noi.
Le strategie adottate sulle persone infettate dal virus, che hanno sviluppato diversi sintomi, più o meno gravi, sono molteplici e comprendono terapie antivirali, idrossiclorochina, anticorpi neutralizzanti, riproposizione di farmaci utilizzati per altri virus e infusione di siero di pazienti in convalescenza da coronavirus.
Lo studio al microscopio di questo virus e del suo meccanismo d’azione ha evidenziato come questo si attacchi in via preferenziale a quelle cellule che hanno sulla loro superficie una molecola detta recettore ACE2, presenti in gran numero negli alveoli polmonari.
Quando il virus raggiunge i polmoni e infetta le cellule genera una tempesta citochinica di molecole infiammatorie, provocando i sintomi peggiori associati al Covid-19, cioè quelli che portano i pazienti in terapia intensiva. Questo ha portato ad indirizzare gli sforzi verso una cura che blocchi la formazione di questa cascata di molecole infiammatorie.
LE CELLULE STAMINALI APPLICATE AL VIRUS
Gli sforzi si sono dunque concentrati su una cura che blocchi la formazione della cascata di molecole infiammatorie, anche se, purtroppo, i trattamenti utilizzati fino ad ora non sempre hanno portato ad un miglioramento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.
Pertanto gli studiosi hanno iniziato a ragionare su cosa potesse dare il maggior effetto antinfiammatorio, facendo ricadere la scelta sulla potenziale azione del trapianto di cellule staminali mesenchimali (MSC), cellule già protagoniste di numerosi studi clinici per l’evidente effetto immunomodulatorio e di mitigazione dell’infiammazione. La Cina, dopo diversi studi clinici, ha fatto da apripista verso questa direzione trapiantando cellule staminali mesenchimali ad alcuni pazienti affetti dal virus. I risultati preliminari hanno dimostrato che il trattamento con cellule staminali mesenchimali era sicuro ed efficace, dati i miglioramenti assunti dai pazienti.
IL PERCHÉ DELLA LORO EFFICACIA E DOVE PRELEVARLE
L’utilizzo di queste cellule risulta particolarmente efficace per via del loro potere immunomodulatorio. Stimolando la riparazione endogena dei tessuti, possono prevenire e ridurre la tempesta di molecole infiammatorie generate dal virus, migliorando al contempo i danni creati dal virus sull’ambiente circostante.
Il trapianto avviene attraverso una semplice infusione e, subito dopo, si vanno ad accumulare nell’organo più colpito, il polmone, proteggendo gli alveoli, prevenendo la fibrosi polmonare e migliorandone la funzionalità.
La fonte migliore da cui estrarre le cellule staminali mesenchimale è la gelatina di Wharton, il tessuto interno al cordone ombelicale.
Le stesse cellule prelevate dal midollo osseo, infatti, non sarebbero molto funzionali allo scopo in quanto al suo interno non è presente un numero elevato di queste cellule ed anche perché le modalità con cui viene effettuato il prelievo renderebbe il tutto più difficoltoso.
Le motivazioni che rendono il cordone una ottima fonte sono diverse:
– Le cellule staminali mesenchimali derivanti dal cordone ombelicale si moltiplicano molto più velocemente di quelle di altre fonti, condizione essenziale per essere una buona cura contro il coronavirus, la quale richiede milioni di cellule per dare un’efficacia clinica.
– Il cordone ombelicale e le cellule in esso contenute vengono prelevati in maniera non invasiva
– Le cellule staminali cordonali hanno delle caratteristiche immunologiche che permettono il trapianto da un paziente diverso dal donatore senza generare rigetto.
PRIMO PAZIENTE ITALIANO
Anche in Italia è avvenuto il primo trattamento di un paziente affetto da Covid-19 con le cellule staminali cordonali, in linea con gli studi effettuati in Cina, Israele e America, riportando risultati soddisfacenti. Si tratta di un paziente di 69 anni affetto da insufficienza respiratoria da Covid-19 e ricoverato presso l’Unità operativa di Terapia intensiva dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, trattato mediante due infusioni di MSC da cordone ombelicale a distanza di una settimana l’una dall’altra. Il trattamento a uso compassionevole non ha causato effetti collaterali e il paziente è sotto stretto monitoraggio clinico. I parametri relativi all’ossigenazione, infiammazione, coagulazione e funzionalità renale sono migliorati.
Questo ha portato a sottoporre all’AIFA una richiesta per una sperimentazione clinica su scala nazionale.
L’incoraggiante notizia di questo miglioramento è in linea con gli studi che stanno avvenendo nel resto del mondo, come negli USA dove la sperimentazione viene portata avanti Dr. Camillo Ricordi, massimo esperto nella terapia cellulare contro il diabete, professore all’Università di Miami ed oggi capo progetto dello studio clinico approvato dall’FDA americana, ha dedicato e dedica la sua vita alle terapie cellulari.
Eseguito come cura compassionevole, lo studio americano porterà 24 pazienti non responsivi ad altre terapie a ricevere più dosi di cellule staminali mesenchimali del cordone ombelicale amplificate in laboratorio. Le cellule iniettate nel circolo venoso si indirizzeranno spontaneamente nel polmone.
Lo studio in questione porterà a risultati in tempi brevi e fornirà scoperte che ci faranno riflettere sul futuro.
I test sierologici per COVID-19: cosa sono, perché farli e quando non conviene
LE DIVERSE PROPOSTE DEI TEST
Ora che siamo entrati nella Fase 2 e il lockdown è terminato, le persone si apprestano ad uscire di casa e le domande che sorgono in vista della convivenza con il virus sono molte: Ho contratto il Covid? Ho sviluppato gli anticorpi? Sono ancora contagioso? Questi interrogativi hanno portato molti italiani ad andare nei laboratori privati per sottoporsi al test sierologico, dopo il gran numero di ordini effettuati dalle Regioni.
Anche molte imprese stanno facendo affidamento a questi test per verificare quanto il virus si sia diffuso tra i loro dipendenti.
COME FUNZIONANO?
Questi test servono a determinare tutte quelle persone che sono entrate in contatto con il Covid-19 raccontando la storia della malattia attraverso l’individuazione degli anticorpi prodotti dal nostro sistema immunitario in risposta al virus e, ad oggi, sono disponibili tre tipi di test sierologici: uno qualitativo ad immunocromatografia, definibile “rapido” (con tempi di risposta di circa 15 minuti ma di minore precisione) e due quantitativi da laboratorio con due metodiche diverse (in chemiluminescenza e in ELISA).
Il test qualitativo riesce a stabilire attraverso una goccia di sangue o poche gocce di siero se una persona ha prodotto anticorpi ed è quindi entrata a contatto con il virus.
I test quantitativi invece, servendosi di un prelievo di sangue, dosano in maniera specifica la quantità di anticorpi prodotti e sono per questo considerati più affidabili.
Entrambi i test cercano due tipi di anticorpi: le IgM (Immunoglobuline M) che, espresse dai linfociti B entro 7 giorni circa dalla comparsa dei sintomi, calano con il tempo il loro livello per lasciar spazio alle IgG (Immunoglobuline G), prodotte dopo 14 giorni dai linfociti B differenziatisi in plasmacellule. Queste ultime indicano che l’infezione si è verificata già da diverso tempo e la tendenziale immunità al virus.
Note aziende di diagnostica, stanno lavorando a diverse categorie di test sierologici quantitativi o semi-quantitativi, al fine di individuare con una sensibilità pari al 99%, diverse classi di immunoglobuline. Alcune metodiche prevedono l’individuazione esclusivamente delle IgG mentre altre offrono un abbinamento tra IgM e IgG.
Inoltre sono al vaglio degli esperti metodiche che offrono la possibilità di avere una diagnosi di Covid-19 mediante test salivare.
COME FUNZIONA IL TEST QUALITATIVO
Il funzionamento del test qualitativo è basato sulla comparsa di 3 bande colorate (simili a quelle dei test di gravidanza), una per il controllo positivo e due per le classi di anticorpi testate.
Le diverse possibilità di risultato offerte da questa tipologia di test sono:
– Comparsa della sola banda di controllo = test negativo
– Comparsa della banda IgM = si è stati contagiati da relativamente poco tempo
– Comparsa della banda IgG = si è stati contagiati e si è guariti
– Comparsa di tutte le bande = si è in fase di remissione della malattia.
PERCHÉ FARLI E QUANDO NON CONVIENE
I test sierologici attualmente assumono valore solo se inseriti in analisi di sieroprevalenza o in indagini di sorveglianza di una popolazione, selezionata nell’ambito di specifici programmi a scopo di valutazione epidemiologica della circolazione virale. Infatti i test presenti oggi sul mercato non ci permettono di sapere se abbiamo conquistato una patente di immunità, cioè scoprire di aver già avuto la malattia e di essere guariti. Neanche se si ricorre ai test quantitativi che permettono di seguire i livelli di anticorpi (titolo anticorpale) di un soggetto nel tempo e vedere se il titolo anticorpale si mantiene sufficientemente alto da garantire la protezione nel tempo. Questo perché, come per altri virus, si devono prima stabilire dei livelli di soglia che permettano di evidenziare un soggetto immune da uno non immune, ovvero si dovrà valutare quali sono i livelli di protezione.
In sostanza i test sierologici, qualitativi e quantitativi, sono test orientativi, non diagnostici, che possono fornire alle persone un’indicazione precisa, ovvero se sono entrate o meno a contatto con il SARS-CoV-2 attraverso la rilevazione degli anticorpi.
Inoltre bisogna sottolineare che risultare negativi al test rapido non significa in assoluto non trovarsi in una fase latente e quindi che le IgM non si siano ancora sviluppate.
Per questo, fino ad ora, l’unica indagine accreditata dal ISS come validazione diagnostica per l’individuazione di Covid-19 resta il test molecolare basato sull’identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei, seguito in RT-PCR, secondo i protocolli indicati dall’OMS, il quale però non da alcuna informazione sull’immunità acquisita e richiede tempistiche più estese (3h/96 test).
Biopsia liquida: applicazioni e vantaggi in oncologia
In un momento delicato come questo, in cui tutto il mondo polarizza la sua attenzione a sconfiggere il coronavirus, la ricerca contro il cancro non si ferma e ottiene risultati significativi nella sua diagnosi precoce.
Stiamo parlando della biopsia liquida, una procedura che può fornire risposte complementari a quelle di altri test biologici e migliorare gli attuali schemi diagnostici.
Una delle applicazioni della biopsia liquida in ambito oncologico maggiormente investigate è lo studio del carcinoma colorettale. Infatti, vista la sentita esigenza sia da parte delle autorità sanitarie sia da parte dei pazienti di una diagnosi precoce del carcinoma colorettale, molte associazioni per i diritti dei pazienti (come la Digestive Cancers Europe) fanno forti pressioni affinché nuovi e più accurati test trovino adozione nella pratica clinica.
COSA SI INTENDE PER BIOPSIA LIQUIDA
Il termine si riferisce alla possibilità di effettuare analisi su materiale di origine tumorale, come cellule, proteine, DNA o RNA, ottenuto da un liquido corporeo, generalmente un prelievo di sangue.
Spesso la biopsia liquida genera dei malintesi, in quanto essa non consente di effettuare una diagnosi di cancro, possibile solamente attraverso l’analisi del tessuto tumorale, ma permette l’identificazione di marcatori prognostici o predittivi.
Il sangue, ottenuto tramite prelievo, viene utilizzato per analizzare la presenza di cellule tumorali circolanti e DNA tumorale circolante. Le cellule tumorali circolanti migrano attraverso i vasi sanguigni dopo essersi distaccati dal tessuto tumorale. Purtroppo l’identificazione e l’isolamento di queste cellule è resa difficile dalla loro bassa frequenza nel sangue dei pazienti e questo, altresì, limita la diffusione su larga scala nella pratica clinica dell’analisi delle cellule tumorali circolanti.
Altra storia invece per quanto riguarda la ricerca del DNA tumorale circolante che, rilasciato nel sangue dalle cellule tumorali morte, è presente in maggior numero e fa sì che tale procedura sia maggiormente utilizzata. In particolare quest’ultima analisi fornisce informazioni importanti, permettendo di riscontrare la presenza o l’assenza di mutazioni in specifici geni del tumore che possono rendere la malattia sensibile o resistente al trattamento con farmaci a bersaglio molecolare.
I VANTAGGI APPORTATI NELLA PRATICA CLINICA
Rispetto alla biopsia tradizionale, decisamente più invasiva e gravata da maggiori complicanze, con la conseguenza di tempistiche lunghe, la biopsia liquida è una procedura rapida e minimamente invasiva, in quanto si tratta di un semplice prelievo ematico con complicanze trascurabili.
Inoltre può essere ripetuta periodicamente in maniera semplice e sicura. Dato che le caratteristiche molecolari del tumore possono variare nel tempo, anche in relazione al trattamento effettuato, la possibilità di avere informazioni aggiornate in tempo reale sull’evoluzione del tumore può fornire un supporto in più all’operatore sanitario nella scelta delle terapie più appropriate. Infine l’analisi di tale DNA può essere integrato in check-up genomici ad ampio raggio che svelino allo stesso tempo molti tipi di tumore.
La biopsia liquida presenta anche un’utilità clinica non trascurabile nel follow-up post chirurgico di quei pazienti che hanno persistenza di alterazioni neoplastiche nel sangue che tendono ad avere un decorso meno favorevole, con recidive e/o metastasi precoci. Infatti sarebbe possibile individuare pazienti che, nonostante siano dichiarati guariti dal chirurgo, presentano ancora qualche piccolo focolaio elusivo (non visibile con la TAC e la PET) e criptico (non sappiamo dove sia) di malattia (malattia minima residua) da qualche parte.